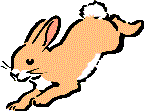|
Li “carusi” nelle solfatare della Sicilia ovvero quando li bambini
siciliani venivano venduti o “affittati” per lavorare nudi nelle
miniere di zolfo anche 16 ore al giorno
Pubblicato il 12 maggio 2015
Un saggio rigoroso e commovente, fra storia e letteratura – di Ugo
Passanisi
Discutere il tema dei carusi significa rievocare una delle pagine più
tragiche, umilianti e vergognose, ma anche meno conosciute della
storia del popolo siciliano. Una storia, in ogni caso, peculiare
della Sicilia che non trova alcun paragonabile riscontro in
avvenimenti consimili in altre regioni del nostro Paese. Quella
dei carusi è una vicenda che inizia nel 1700 e che si sviluppa
per oltre due secoli fino alla metà del ‘900. Inizia con i
Borboni ai quali sopravvive, e continuerà in seguito anche dopo
l’annessione del Regno delle Due Sicilie alla corona dei Savoia
e alla proclamazione a primo re d’Italia di Vittorio Emanuele
II. Con il nuovo regime, infatti, nulla cambia per la Sicilia,
anzi, le rivolte contadine contro il latifondo sono soffocate
nel sangue dai garibaldini di Nino Bixio, come è avvenuto – ma
non sarà il solo caso – con il processo sommario e l’eccidio di
Bronte. I grandi proprietari terrieri hanno mantenuto
saldamente nelle loro mani il possesso del territorio, e sono
andate deluse le grandi attese di riscatto riposte in Garibaldi
e nel nuovo regime dai braccianti affamati di terra – i
cosiddetti “picciotti” tanto esaltati dalla retorica
risorgimentale – che pure, per questo motivo e con questa
speranza sono accorsi in massa sotto le sue bandiere. La Destra
storica ha imposto ancora una volta la sua legge e, come sotto i
Borboni, la miseria continua a regnare sovrana nelle campagne
dell’Isola. Questa premessa è indispensabile per spiegare le
ragioni profonde che, nella seconda metà dell’800 e nel primo
‘900, hanno determinato l’esodo massiccio di migliaia di
siciliani, giovani, vecchi e bambini, non solo verso le Americhe,
ma anche, per coloro che sono rimasti, dal contado alle miniere.
E in questo contesto storico, in questa situazione sociale,
perciò, non può cambiare, anzi riceve maggiore impulso la
drammatica vicenda dei carusi. Ma, chi sono questi
carusi ? Con il termine carusi vengono indicati i
bambini e i ragazzi costretti dall’indigenza economica delle
loro famiglie a lavorare nelle miniere di zolfo. Il termine
pare sia derivato dalla consuetudine di rasare completamente la
testa di questi giovanissimi lavoratori, probabilmente per i
motivi igienici conseguenti alle condizioni di estrema sporcizia
esistenti nelle miniere: tale taglio di capelli veniva di fatto
definito nel dialetto tipico dell’epoca della zona di
Caltanissetta come tagghiu carusu, mentre successivamente
servirà a indicare genericamente i bambini dai 5 ai 12 anni
circa. Ancora oggi, segnatamente nel catanese, ma anche in altre
zone della Sicilia, le parole carusu, carusazzu, identificano il
“ragazzo”, il “ragazzaccio”.
C’è da dire che, anche secondo la legislazione del tempo, era
illegale impiegare nel lavoro manuale un minore di 12 anni in
quanto la legge stabiliva, già allora, che la scuola dovesse
essere obbligatoria per i bambini fino alla terza classe
elementare. Tuttavia, questa disposizione veniva largamente
disattesa a causa della miseria nella quale vivevano le famiglie
contadine che costringeva tutti al lavoro nei campi fin dalla
più giovane età, come è dimostrato dal fatto che l’analfabetismo
raggiungeva, particolarmente nelle campagne, percentuali
altissime, assai vicine al 100%. Del resto, le autorità
governative dell’epoca si preoccupavano di tutto fuorché di
farla rispettare, attente com’erano a non venire in conflitto
con gli interessi economici della grassa borghesia costituita
dai proprietari terrieri, da cui erano lautamente foraggiate,
che traeva lauti guadagni dallo sfruttamento del lavoro minorile.
Per lo stesso motivo nessun controllo veniva esercitato sulle
condizioni di lavoro nelle miniere che erano durissime,
addirittura inaccettabili secondo gli standard odierni di
sicurezza, mentre il rispetto dei diritti umani, dell’infanzia e
dei lavoratori, erano pressoché inesistenti. L’orario di lavoro,
infatti, poteva arrivare anche a sedici ore giornaliere, e i
ragazzi subivano abitualmente maltrattamenti e punizioni
corporali se accusati di mancanze di qualsiasi genere o di
scarso rendimento senza che alcuno avesse il potere di
intervenire in loro difesa. Ai genitori dei ragazzi arruolati
come manovalanza nelle miniere veniva corrisposto un pagamento
anticipato, che poteva variare da 100 a 200 lire, chiamato
“soccorso morto”.
In pratica si trattava di un vero e proprio prezzo di
compravendita poiché la paga dei carusi era di pochi centesimi
al giorno dalla quale veniva dedotto il costo del vitto fornito
dal picconiere alle cui dirette dipendenze i carusi
lavoravano, chiamato “spesa”, spesso costituito da alimenti di
pessima qualità, o addirittura di solo pane, fornito inoltre ad
un prezzo esoso. Ai genitori dei ragazzi era quindi
praticamente preclusa ogni possibilità di riscatto dei propri
figli che divenivano, di fatto, proprietà esclusiva del
picconiere che li aveva acquistati e che poteva disporre di
loro a suo piacimento. Le condizioni di vita dei carusi hanno
trovato larga eco nel passato nella letteratura siciliana. Le
descrive ampiamente Giovanni Verga nel racconto “Rosso
Malpelo”, e così ne parla Luigi Pirandello nella sua novella
“Ciaula scopre la luna”: “Nelle dure facce quasi
spente dal buio crudo delle cave sotterranee, nel corpo
sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate,
avevano il livido squallore di quelle terre senza un filo d’erba,
sforacchiate dalle zolfare, come tanti enormi formicai …. Ciàula
si mosse sotto il carico enorme, che richiedeva anche uno sforzo
di equilibrio. Sì, ecco, sì, poteva muoversi, almeno finché
andava in piano. Ma come sollevar quel peso, quando sarebbe
cominciata la salita?”
Ed è ricchissimo, poi, il repertorio poetico e di canti popolari
dal quale traspare la cupa rassegnazione degli zolfatari alla
loro misera sorte, anche se non ancora la rabbia e la ribellione
contro lo sfruttamento che sarebbero maturati solo molto più
tardi, nei primi decenni del ‘900, grazie alle lotte di
sindacalisti agguerriti e combattivi. Anche in tempi moderni la
tragedia di questi ragazzi è stata rievocata da Andrea Camilleri
nel suo romanzo “Il sonaglio”. In questo racconto il
reclutatore di bambini così si rivolge a un gruppo di madri in
ascolto: “Mi chiamo Filibertu Alagna e vengo da un paisi
ricco che si chiama Alagona. L’aviti ‘ntiso nominari? E’ un
paisi ricco pirchì havi cinco minere che sunno i posti indove
scavanno veni fora il surfaro…. Nelle minere travagliano, pagati
bono, òmini granni, carusi e picciotteddri. L’etati dei carusi
va dai se’ all’unnici anni, quella dei picciotteddri dai dudici
ai diciotto. Per ogni jornata di travaglio al caruso spettano
ottantacinco cintesimi, al picciotteddro ‘nveci novanta. Vi
spiego come funziona la facenna. Ogni caruso o picciotteddro
veni pigliato in custoddia da un picconeri, il quale ci pensa
lui a darigli da mangiari, naturalmente tinennosi qualichi
cintesimo dalla paga. Ma ccà veni il bello. Il picconeri, in
cangio di vostro figlio, vi duna ‘na cosa che si chiama soccorso
morto. Soccorso significa aiuto e morto veni a diri che voi ve
lo pigliate e non doviti arrestituirglielo. Il soccorso morto
consisti in ducento liri, arripeto, ducento liri, che io vi
dugno manu cu’ mano, e per conto del picconeri, al momento nel
quale mi consegnate vostro figlio. Se minni date dù, io vi
dugno quattrocento liri, se minni dati tri io vi dugno seicento
liri. Mi state accapennu? Questi sordi addiventano vostri e vui
ne potiti fari quello che voliti e non doviti renniri cunto a
nisciuno. Pinsatici bono. Un caruso sino a deci, unnici anni,
che vi rappresenta ‘n famiglia? Un piso. Non travaglia ed è ‘na
vucca da sfamari. Dànnolo a mia, il caruso travaglia e guadagna,
non vi pisa cchiù supra alli spalli e vui v’attrovati ad aviri
‘n mano tanto dinaro che manco in sogno. Parlatene a tutte le
fimmine che accanoscite e parlatene coi mariti vostri. Io sugnu
alla pinsioni Pace. Portatemi i figli vostri e io ve li pago
subito. V’avverto: resto ancora tri jorni. Non facitivi scappari
la fortuna.”
Dunque un discorso persuasivo ed estremamente convincente
per chi, giornalmente, è costretto a tagliare col coltello la
fame propria e quella della propria famiglia. E infatti Zina,
una delle donne presenti, ne parla col marito Adelio,
poverissimo pescatore la cui attività gli consente a stento di
sopravvivere alla miseria più nera. Adelio esita, non vorrebbe
privarsi del figlio che lo aiuta nel suo lavoro, ma la proposta
è allettante e, alla fine, spinto dalla necessità, decide di
chiedere consiglio al suo unico cliente, un certo Don Pitrino
Vadalà. Ma come e dove nasce in Sicilia l’industria dello zolfo?
Siamo nel cosiddetto altipiano dello zolfo, quello che da
Caltanissetta va ad Agrigento. Se si guarda una cartina
geologica della Sicilia dove i giacimenti di zolfo sono segnati
a macchie rosse, si vede che le sparse tracce, partendo dai
territori di Calatafimi e di Lercara Friddi e, nel catanese e
nell’ennese, da Assoro a Licodia Eubea, a mano a mano si
infittiscono tra Cianciana e Valguarnera, diventando un continuo
lago rosso attorno ad Agrigento, da Aragona a Serradifalco. Già
al tempo dei Romani abbiamo notizia che lo zolfo affiorante
viene raccolto, e quello sotterraneo viene scavato, fuso, e poi
solidificato in pani, come è attestato dalle lastre di
terracotta col marchio di Racalmuto conservate al Museo
Nazionale di Palermo, per essere poi impiegato in medicina e nel
trattamento delle stoffe.
Ma quella che è la storia vera e propria dell’industria
zolfifera dell’Isola, dell’estrazione sistematica dello zolfo e
della sua esportazione, comincia, come abbiamo detto, nel ‘700
sotto i Borboni con la prima rivoluzione industriale e con la
scoperta di un nuovo metodo di preparazione dell’acido solforico
che aveva larghissimo utilizzo nell’industria tessile e in
quella bellica degli esplosivi. Lo scoprono per primi, e ne
intuiscono le enormi potenzialità economiche, gli imprenditori
francesi e inglesi. Una compagnia francese, in particolare,
avrebbe voluto creare un’industria di lavorazione sul posto
costruendo una raffineria di zolfo con due camere di
sublimazione a Porto Empedocle. La stessa compagnia richiese
poi il monopolio di compravendita dello zolfo siciliano, ma
poiché gli inglesi minacciavano di bombardare i porti del
meridione se questa richiesta non fosse stata respinta,
Ferdinando II di Borbone, nel 1836, fu costretto a revocare la
concessione e a sciogliere la società. Ciò stroncò una grande
occasione economica per la Sicilia a tutto vantaggio degli
esportatori stranieri, principalmente francesi e inglesi, i soli,
insieme a pochissimi proprietari terrieri siciliani, a essersi
arricchiti con lo sfruttamento del sottosuolo dell’Isola, senza
che mai i proventi di questa ricchezza del nostro territorio
fossero reinvestiti in Sicilia. Lo zolfo siciliano, di ottima
qualità, imbarcato su velieri, veniva inviato a Marsiglia per
essere poi lavorato all’estero per i mercati francese e
britannico. Ancora una volta la Sicilia venne trattata come una
colonia da sfruttare e dovette soccombere alla prepotenza dello
straniero. Già sul finire di quel secolo attivissime erano le
miniere di Palma di Montechiaro, Petralia Sottana, Racalmuto,
Riesi, San Cataldo, Caltanisseta, Favara, Agrigento, Comitini,
Licodia Eubea. Nel 1890 ne sarebbero state in esercizio ben 480
e nei primi anni del ‘900 le miniere attive sarebbero diventate
886 con circa 40.000 occupati. La febbre dello zolfo prende
tutti: proprietari terrieri, gabelloti, picconieri, commercianti,
magazzinieri, carrettieri, artigiani, carusi. Coinvolge
imprenditori stranieri e speculatori di ogni nazionalità.
Attira masse di uomini dai popolosi paesi dell’interno
dell’Isola, dai miseri centri del feudo, in questa sterminata
landa dove, da secoli, le possibilità di lavoro dipendono dal
capriccio del gabelloto e dei suoi sottostanti, dalla soggezione
a costoro; dove le giornate lavorative si riducono a poche
nell’arco dell’anno; dove il contadino è angariato da tasse,
decime e balzelli di ogni tipo a cui bisogna aggiungere le
tangenti illegali; dove le squadre di lavoratori stagionali,
mietitori e spigolatori, sono costrette al nomadismo; dove la
vita, insomma, raggiunge inimmaginabili livelli di sfruttamento
e di miseria. La miniera, dunque, appare come un miraggio nel
deserto e offre una speranza di riscatto a una moltitudine di
miserabili diseredati. E’ una febbre che cresce col tempo e si
sviluppa nell’arco di due secoli fino al ‘900, quando, per la
concorrenza sui mercati internazionali dello zolfo americano,
decresce fino a sparire del tutto negli anni ’60, lasciando
tutto come prima, peggio di prima, com’è destino di questa terra
infelice, come avverrà – poiché la Storia si ripete – negli
anni ’90 con l’industria petrolifera e petrolchimica, com’è
successo nel primo decennio del 2000 con l’industria
automobilistica a Termini Imerese. Nel 1934 una legge dello
Stato italiano vietò alle donne e ai ragazzi di età inferiore ai
16 anni di calarsi all’interno delle zolfare mentre già da
qualche anno prima, nel 1927, era stata sancita per legge la
demanialità del sottosuolo. Solo lo Stato poteva assegnare in
concessione, perpetua o temporanea, lo sfruttamento dei
giacimenti. Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale,
malgrado gli interventi governativi prima e regionali dopo,
malgrado la nascita nel 1963 dell’Ente Minerario Siciliano, l’
E.M.S., continuò il declino dell’attività estrattiva dello zolfo
e, a una a una, le miniere chiusero irreversibilmente. E un
destino ancora peggiore è toccato alle miniere di sali potassici
di Pasquasia, dapprima abbandonate e successivamente trasformate
in un deposito di migliaia di tonnellate di amianto e, pare, di
scorie nucleari.
Ma, in ogni caso, al di là della concorrenza americana,
l’industria mineraria siciliana non poteva avere prospettive di
sopravvivenza a causa della carenza di capitali da investire
nella modernizzazione degli impianti di estrazione, delle
infrastrutture, strade e ferrovie, per l’insufficienza dei porti,
per la mancanza di spirito imprenditoriale, per la pochezza
dell’industria chimica isolana. Quella della zolfara è stata,
dunque, una storia triste di miseria, di sfruttamento
indiscriminato, di sofferenze indicibili, di morte, di
abbrutimento, di negazione della dignità umana. Sull’altipiano
sono rimasti l’amaro della delusione e della sconfitta, un mare
di detriti, cumuli immensi di scorie, un vasto cimitero di
caverne risonanti, di miniere morte, di tralicci arrugginiti, di
binari contorti dei carrelli. Qui sono tornati a ricrescere i
cespugli spinosi del deserto, sono tornate a strisciare le serpi,
a volteggiare i corvi. Purtroppo la Storia, quella con la “S”
maiuscola, non è mai servita a insegnare qualcosa agli uomini:
solo oggi, forse, si comincia a comprendere che la vocazione di
questa nostra terra, ricchissima di storia, di reperti
archeologici unici al mondo, di splendide spiagge, di isole e
arcipelaghi meravigliosi, di bellezze naturali e
architettoniche senza pari, non può essere quella industriale,
ma che il suo futuro risiede soltanto nello sviluppo di
un’agricoltura razionale, moderna e meccanizzata, e, soprattutto,
di un turismo di qualità.
Si pensi, solo
per un momento e per fare un esempio che è sotto i nostri occhi,
che cosa avrebbe potuto costituire dal punto di vista turistico,
e quale grandiosa occasione di sviluppo occupazionale avrebbe
potuto rappresentare la valorizzazione della fascia costiera che,
dalle foci del Mulinello e del Marcellino, dall’Hangar
dirigibili di Augusta, passando per le rovine di Mègara Hyblaea
giunge a Thapsos nella penisola Magnisi, al seno di Priolo e
oltre: al suo confronto la tanto celebrata costiera adriatica
farebbe la figura della parente povera. Porticcioli turistici,
alberghi, ritrovi, night, luoghi di ristoro e di sport acquatici,
pescaturismo, spiagge tropicali, un mare cristallino, tutto
nell’ambito protetto della rada: un sogno, a fronte del quale
rimane un deserto di rottami industriali arrugginiti, una terra
avvelenata dai rifiuti tossici, un mare inquinato da veleni di
ogni tipo, una costa deturpata per secoli, forse per sempre. E
il cancro. Ma vediamo com’era organizzata, in quei due
secoli passati, l’attività della miniera. In superficie,
rintanati nei loro palazzi di Palermo, di Agrigento e di Catania,
i proprietari dei terreni che, per legge, erano anche
proprietari del sottosuolo, non ancora considerato proprietà
demaniale, i quali, senza alcun rischio né preoccupazione,
ricevevano dal gabelloto, cioè dal concessionario, l’estaglio, cioè
una quota del profitto, che poteva raggiungere il 30% derivante
dalla vendita del prodotto. C’era poi una vasta categoria
parassitaria che traeva profitto dal lavoro della miniera,
costituita dagli sborsanti, cioè dai finanziatori, dai
gabelloti, dai magazzinieri, dagli esportatori. E poi i
carrettieri, i fabbri, i bottegai, cioè coloro che oggi, insomma,
chiameremmo l’indotto. Alla lavorazione dello zolfo
estratto erano addetti i calcaronai, incaricati della
preparazione dei calcaroni, cioè delle fornaci, gli arditori,
preposti alla fusione dello zolfo, i vagonai che
spingevano i carrelli carichi sui binari, dall’imboccatura della
miniera fino ai calcaroni.
E tutto questo apparato poggiava principalmente sulle spalle di due
soli lavoratori: il picconiere e il caruso. L’uno, che a colpi
di piccone estraeva lo zolfo dalle viscere della terra; l’altro,
che sulle sue spalle lo trasportava in superficie, a due o
trecento e più metri d’altezza, arrampicandosi su gradini
scavati nella roccia con pendenze ripidissime, servendosi di
ceste contenenti fino a 35 chili di zolfo i più piccoli e fino a
80 chili i ragazzi più grandi. Ogni picconiere impiegava in
media da due a quattro carusi. Nella galleria la temperatura
arriva a 50° c. Manca l’aria. Completamente nudi, grondando
sudore e contratti sotto i gravosissimi pesi che portavano, una
volta usciti all’aria aperta, spesso gelida, i carusi
scaricavano il materiale nei carrelli che altri ragazzi
spingevano fino alla bocca dei calcaroni, sempre correndo,
incitati, spintonati, spesso frustati e bastonati come bestie
con bastoni e tubi di gomma, in condizioni incredibili di
crudele sfruttamento. Impossibile allontanarsi dal lavoro anche
per pochi minuti, nemmeno per urgenti bisogni corporali. Se
proprio non se ne poteva fare a meno, si doveva riportare la
caldarella piena, a dimostrazione dell’avvenuto bisogno e
mostrarla ai sorveglianti. Dai verbali dei processi degli anni
’50 contro lo sfruttamento minorile, segnatamente di quello
celebrato a Lercara in cui era imputato un certo Ferrara,
proprietario di miniere della zona, emerge un quadro
terrificante di abusi e di violenze, un vero girone dantesco di
dannati. Naturalmente in questo processo tutti gli imputati si
proclamarono innocenti attribuendo le accuse di malversazioni e
di comportamenti illegali alle calunnie dei sindacalisti
comunisti o a speculazioni politiche: inutile difesa, smentita
dalle dettagliate testimonianze dei carusi e da ben 65 perizie
mediche ordinate dal Tribunale a un collegio di medici
palermitani.
Testimonianze agghiaccianti, come quella di Beniamino Minutella
di 14 anni al Giudice Istruttore: “Ero addetto a scavare col
piccone il piano dei fossati per abbassarne il livello al fine
di procurare la fuoriuscita dell’acqua. Per eseguire tale lavoro
ero costretto a stare con l’acqua che mi arrivava ai ginocchi,
Il lavoro iniziava alle 16 e terminava alle 4 di notte. A causa
dell’umidità e della polvere che si respira gli occhi si
infiammano e bruciano al punto che si è costretti ad andare
all’aperto. Succede spesso che il Ferrara alle nostre
rimostranze perché non ci fornisce gli stivali, ci risponda:
state lì a crepare nell’acqua fino a farvi schiattare il cuore”.
E questa la deposizione di Antonino Marsala di soli 11 anni:
“Confermo le dichiarazioni rese al Pretore, Lavoravo 12 ore al
giorno, dalle 6 alle 18. Fui sottoposto a bastonature dai
sorveglianti perché non tenevo il ritmo che si voleva. In
qualità di caruso ero addetto al trasporto di caldarelle di
zolfo del peso di 35 chili. Preciso che una volta, mentre mi
trovavo in miniera, Giuseppe Modica mi diede una pedata e mi
ferì all’occhio sinistro producendomi una lesione di cui ancora
porto la cicatrice. Non mi fece medicare e mi limitai a fasciare
l’occhio con un fazzoletto e dovetti continuare a lavorare …”
E di deposizioni come queste, più o meno tutte dello stesso
tenore, ce ne sono 65 agli atti del processo. Ma quella che mi
sembra, più di ogni altra, commovente ed emotivamente
significativa è la seguente descrizione anonima del lavoro in
miniera nella quale mi sono imbattuto nel corso delle mie
ricerche su questo affascinante argomento storico:
“L’ascensore inizia a scendere dopo un piccolo sobbalzo. Il
rumore della ferraglia è assordante. Man mano il cielo sopra di
loro sparisce. I loro volti sono rassegnati, accostati uno
all’altro come bestie in quell’ascensore della miniera, che li
ingoia come un verme senza fondo. L’ultimo sguardo a quel cielo
.Chissà se lo rivedranno. Stretto al petto tengono quel misero
involto di pane e olive. I carusi, bambini dagli 8 ai 12 anni,
ben presto hanno lasciato i loro giochi. E non sono le ginocchia
ad essere sbucciate, giocando a pallone, ma le mani spaccate dal
lavoro. Visi smunti, impauriti, mentre scendono insieme ai
grandi in quel buco nero. Il caldo aumenta man mano che si
scende e l’aria è poca portata dagli sfiatatoi che scorrono
lungo le gallerie. Nudi scavano nelle gallerie carusi e adulti.
Vecchi e giovani sudati e impastati di quello zolfo strappato
alla roccia. Muli insieme ai muli, ormai ciechi, che servono a
tirare i carrelli col materiale al montacarichi. Chissà che
colore ha il cielo oggi. Chissà cosa pensano i carusi mentre
respirano a fatica in quella bolgia di polvere e buio. Inferno
sulla terra. Morti prima di nascere. E quanti, stretti ai loro
compagni, sono morti rimanendo sepolti da gallerie crollate o da
quel maledetto gas. Trabonella, Gessolungo …. miniere una volta,
ora cimiteri, dove nessuno ha portato mai fiori, dove le urla
strazianti delle madri si sono perse ingoiate dal tempo.
Figli di questa terra, morti nel suo ventre, vi ricordo ogni
volta che vedo quelle torri che ormai cedono arrugginite. Non
una tomba su di voi, né terra benedetta. Le conseguenze
fisiche per i carusi utilizzati nelle miniere furono terribili e
tali da segnarli per tutta la vita: cecità, rachitismo,
deformazioni scheletriche, malattie irreversibili dell’apparato
respiratorio dovute alla polvere, allo zolfo, e ai continui
sbalzi di temperatura tra il caldo asfissiante della miniera e
l’aria gelida esterna. Moltissimi i morti in giovanissima età,
e, tutti quelli che sopravvissero, quasi tutti ingobbiti,
dichiarati inabili al servizio militare. Innumerevoli gli
incidenti e le vittime per le esplosioni di “grisou”, il gas
micidiale e inodore la cui presenza nelle gallerie poteva essere
rivelata solo dai cardellini che i minatori portavano con sé in
piccole gabbie affinché, con la loro morte improvvisa,
segnalassero il pericolo imminente. Ciò, tuttavia, spesso
avveniva troppo tardi perché gli uomini intrappolati nei bassi
e tortuosi cunicoli potessero salvarsi fuggendo in tempo
all’aperto. Una lapide posta nei pressi di una miniera a cura
dell’ Associazione “Amici della Miniera” di Caltanissetta
riporta la seguente iscrizione: “Nella Valle delle Zolfare
quel mattino pioveva. Correva l’anno 1881, erano le 6 del 12
novembre. 120 minatori che lavoravano nella miniera Gessolungo
sezione “Calafato” di contrada Juncio, si accingevano a
raggiungere i propri cantieri in sotterraneo percorrendo la
galleria “Piana”, quando improvvisamente furono investiti da un
violento incendio causato dallo scoppio di “grisou”prodotto
dalla fiamma di una lampada ad acetilene.55 minatori, anche se
feriti, riuscirono a raggiungere l’esterno e mettersi in salvo.
Per gli altri 65 fu la fine. 16 di loro feriti gravemente
morirono in ospedale. Gli altri 49 recuperati dopo venti giorni
sono stati sepolti in questo luogo. Tra loro ci sono 19 “carusi”
di età da 8 a 14 anni. Nove sono rimasti ignoti. Viandante,
ricordali per le loro sofferenze, il sacrificio e la vita
violentemente spezzata ed eleva una preghiera a Dio.Novembre
2001”
In un altro incidente in miniera in una sola volta morirono 150
carusi e, sulla stele che li ricorda, 28 sono senza nome.
Queste storie, questo mondo scomparso, quest’illusione che non
migliorò la condizione della gente di Sicilia rivivono oggi
grazie all’istituzione della Riserva posta fra Aidone, Piazza
Armerina e Valguarnera, nell’ennese. Negli anni ’80, ad attività
estrattiva conclusa, nacque l’esigenza di non disperdere quel
patrimonio ma, anzi, di utilizzarlo come leva per lo sviluppo
locale, offrendo ai turisti la possibilità di visitare quello
che è considerato il parco di archeologia industriale più grande
ed interessante del mondo, un vero e proprio museo all’aria
aperta. Nei tre siti estrattivi di Fioristella, Grottacalda e
Gallizzi, 400 ettari immersi nei boschi tornano a colonizzare
quell’area un tempo resa sterile dall’anidride solforosa
liberata dalla combustione dello zolfo: natura e miniera oggi
riescono a convivere dopo essere stati, per oltre due secoli,
tra loro incompatibili. Infine, e per concludere, mi sia
consentita un’annotazione personale e inedita a margine di
queste mie ricerche. Contrariamente a quanto potrebbe far
pensare l’allegro “trallalleru” del ritornello e il motivo
accattivante, “Vitti ‘na crozza”, elaborata dal maestro
agrigentino Francesco Li Causi, e resa famosa da Rossana
Fratello nella colonna sonora del film di Pietro Germi “Il
cammino della speranza”, è una canzone triste e, amio avviso, è
zolfatara. Protagonista del canto è una crozza, un teschio, che
racconta il suo dolore per non aver avuto, nel giorno della
morte, nemmeno un rintocco di campana. Un’usanza, quest’ultima,
imposta dalla Chiesa del tempo che vietava i rintocchi a morto
per chi spirava tra le viscere della terra. La morte in
galleria era vista, dunque, come una punizione divina per i
peccati commessi. Colui che moriva in miniera non aveva nemmeno
diritto al funerale ecclesiastico e veniva portato direttamente
al cimitero. Il cannuni su cui appoggia il teschio non è, perciò,
la canna della temibile arma – cosa che non avrebbe significato
– ma, nel gergo solfataro, la vucca, cioè il boccaporto,
l’ingresso della miniera, dove la crozza invoca disperatamente
la pace dell’anima, irraggiungibile finché una mano pietosa non
ne avrà ricomposto i resti. Questa è, lo so bene, solo una delle
tante versioni e dei tanti significati che sono stati attribuiti
nel tempo a questa famosissima canzone siciliana, la cui origine
pare risalire all’800, e di cui esistono testi e interpretazioni
tanto diversi tra loro.
A me, però, da
profano, è sembrata, non solo la più suggestiva, ma anche la più
realistica, così come mi è sembrato doveroso, se la mia opinione
è quella giusta, sottrarre questo meraviglioso canto
all’equivoco che da lungo tempo l’ha avvolto e che, in ogni caso,
ne ha fatto uno dei più noti motivi della nostra tradizione, a
riprova di quanto la vicenda dello zolfo e dei carusi abbia
inciso sulla letteratura, arte, costume e folklore della Sicilia,
e segnato la vita della nostra gente.
La chiusura delle miniere di zolfo, di salgemma e di sali
potassici in Sicilia pose fine, come abbiamo visto, alla
tragedia dei carusi, ma non a quella dei minatori siciliani. L’8
agosto 1956, infatti, si consumava in Belgio una delle
catastrofi minerarie più tragiche della storia dell’Europa
occidentale. Nella miniera di Marcinelle perirono 262 minatori,
136 dei quali, più della metà quindi, erano siciliani. Si
trattava di poveri sventurati che avevano trovato il modo di
continuare a corrodersi i polmoni nelle miniere di carbone
belghe. Dieci anni prima, il 23 giugno 1946 il governo italiano
aveva stipulato e sottoscritto con quello belga un accordo
criminale e scellerato in forza del quale l’Italia avrebbe
acquistato carbone dal Belgio a prezzo agevolato in cambio
dell’invio di 50.000 minatori che, per un certo numero di anni,
non avrebbero dovuto né potuto cambiare lavoro, pena l’arresto.
In pratica, carne umana in cambio di energia. I minatori
siciliani lasciarono la loro terra con tanti dubbi e tre sole
certezze: la prima, che la guerra per loro non era finita; la
seconda, che prima o poi si sarebbero ammalati di silicosi; la
terza, che molti di loro non sarebbero più tornati a casa.
Quella che segue è la testimonianza di uno di loro, siciliano di
Augusta, Salvatore Agrillo, resa in un suo scritto inedito dal
titolo “Storia di un minatore siciliano” che ho avuto la
ventura di poter leggere: “Vengo dal mare, dalla terra dei
vulcani,da una terra secca e calcarea. Ero giovane e vigoroso.
Avendo sentito parlare di lavoro all’estero, mi ci sono
interessato. Mi decisi di andare a vedere questi paesi lontani
dei quali sognavo. Presi la decisione di partire per il Belgio e
le sue miniere. Con le carte in regola, annunciai la mia
decisione ai miei genitori. Si opposero ma alla fine accettarono
la mia decisione. Ho rassicurato tutti, i miei genitori, i miei
fratelli e le mie sorelle. Dicevo loro che avrei fatto fortuna e
che li avrei aiutati a vivere meglio perché la vita era molto
dura a quell’epoca, nel dopoguerra. Presi il treno ad Augusta,
la mia città natale, in uno degli ultimi convogli di lavoratori
emigranti del 1946. Partii per il Belgio. Il convoglio
attraversava lentamente l’Italia. Dopo alcuni giorni di viaggio
e numerose peripezie il treno arrivò a destinazione, cioè Boussu.
In quel posto, all’inizio rimasi deluso, tutto era nero; io che
venivo dal paese del sole e dell’acqua colore azzurro. Ma mi
rassegnai. Ero venuto lì per lavorare. Poi mi installai con i
miei futuri colleghi di lavoro in piccole casette. Incominciai a
lavorare alla “Sentinelle” e poi all’ “Alliance” e alcuni anni
più tardi a “Vedette de Saint-Antoine”.
Nel frattempo ci fu un reclutamento per comporre una squadra di
salvataggio e ne presi parte con fierezza. Continuavo a seguire
i corsi di salvataggio e sopravvivenza e a lavorare. Lavorai per
17 anni nel profondo delle miniere. Qualche volta mi ferivo ma
non gravemente. Però alcuni miei compagni persero la vita lì
sotto. Nel ’59, alla “Sentinelle”, durante un’avanzata nel
taglio della pietra, una falda di acqua sotterranea fu bucata e
inondò parecchie gallerie che erano destinate a mettere dei
cavalli condannati a lavorare nel fondo. Per un mese, curai,
feci mangiare e pulii un cavallo. Ogni giorno mi occupavo di lui
e un legame si era instaurato tra lui e me. Riconosceva i miei
passi e il mio fischio. Era contento di vedermi ogni volta. Più
avanti si è potuto far risalire il cavallo ed egli fu chiamato
“Noè” perché era stato salvato dalle acque. Per questo atto
ricevetti una medaglia d’argento contro la crudeltà verso gli
animali.
Alcuni salvataggi hanno avuto meno successo. Un esempio fra gli
altri fu “Marcasse”. Una perdita di grisou. Nessuno si salvò.
Poi venne la catastrofe, la più terribile che il paese abbia
conosciuto: “Le Bois du Casier à Marcinelles”. Arrivata in
autunno, la mia squadra del “grand trait de Frameries” lavorò un
mese intero al salvataggio di questi uomini bloccati nel fondo
della miniera. Sfortunatamente il numero delle vittime fu
pesante. Più di 250 persero la vita. Numerose scene erano
spaventevoli da vedere e ci sono voluti forza e coraggio per
rimontare in superficie tutti quei corpi senza vita e renderli
alle loro famiglie, le quali aspettavano questi uomini vivi con
tanta speranza. Alla fine di questo terribile salvataggio, la
squadra ricevette una delle più alte distinzioni per questo atto
umanitario: il “Carnegie Hero Fund”. Dal Governo italiano
ricevetti l’ “Ordine della Stella della Solidarietà”. La mia
squadra e io ricevemmo dalle mani del Re Baudoin le
congratulazioni, gli onori ed i ringraziamenti delle famiglie
dei minatori defunti. E infine abbiamo ricevuto per quell’atto
umanitario una Medaglia d’oro dal Governo belga. Sì, ho
veramente amato il mio mestiere di minatore di fondo e ne sono
molto fiero. A tutti i miei colleghi vivi, quando verranno lì
dove sono io ora, parleremo di nuovo tra di noi, di storie
vissute a Bouviaux, di carbone e di grisou. Ecco la storia di un
minatore di fondo chiamato Agrillo Salvatore.” Una storia
semplice e genuina, come l’uomo che l’ha narrata, e che non ha
bisogno di alcun commento.
Ugo Passanisi |